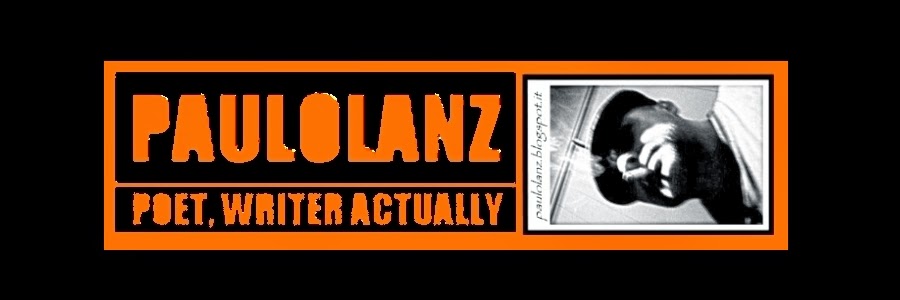Ogni venerdì pomeriggio lo passava in un
centro di bellezza. Il più caro, il più esclusivo, il più ambito. Ma lei amava andarci solo per osservare le donne che lo frequentavano. Altolocate,
figlie e mogli dell’elite politico-economica, giovani in carriera, escort o
semplici mantenute. Quel posto era particolarmente curato, una spa
spettacolare, il suo canonico trattamento partiva con un massaggio rilassante
per poi finire con una ritoccatina di trucco
e parrucco. Infine una tisana nel piccolo angolo bar con chiacchiere su
banalità e ovvietà. In realtà ciò che particolarmente l’attirava di quel luogo
era stare prevalentemente nuda in mezzo ad altre donne; e questo non per un
fatto sessuale, nonostante la relazione che aveva con Cristiana lei si sentiva assolutamente eterosessuale, bensì per
vedere a nudo quelle donne. Quella condizione era livellante, tutte erano alla
pari, non che lei si sentisse fuori posto o non adeguata visto che di denaro ne
aveva molto e forse più di tante altre, ma solo perché si sentiva diversa. Le
squadrava, si soffermava sulle imperfezioni fisiche, le decine di portesi
mammarie di varie forma e dimensione erano tra gli obiettivi preferiti. Non fu
mai in grado di comprendere il motivo per cui una donna si rifacesse il seno ma
c’era di più. Quelle artefatte le parevano tutte simili oltre che nelle tette
pure nelle simmetrie dei visi, nei rigonfiamenti botulinici, in quelle pelle
lucide tanto levigate da sembrare pronte a criccarsi improvvisamente. E poi la
gestione del pelo pubico: argomento che le stava particolarmente a cuore dopo
le lunghe chiacchierate con Cristiana
sull’argomento. La maggior parte erano completamente depilate, altre con un
ciuffetto, poche con il triangolo ben disegnato. Ognuna la mostrava più o meno
consciamente presumendo di essere migliore, lanciatrici di fugaci occhiate a
vagine altrui ben attente a non farsi scorge, intime riflessioni riguardo le
abitudini della proprietaria. Cose che, seppe un giorno, era abituale anche fra
gli uomini che non possono fare a meno di guardare in occasioni simili i peni
degli altri maschi con l’inevitabile confronto. Ma quella parola proprio non le
era mai piaciuta: non era e non voleva mettersi dentro ad alcun confronto, credeva
solamente ad una cosa dopo anni di osservazioni di vagine e frequentazioni di
ambiti sessuali eccessivi o estremi. Ogni donna è lo specchio della sua vagina.
La moglie del ministro dal taglio pubico triangolare abbastanza folto fu per lei
sempre una donna innamorata d’un marito traditore che non era da tempo più
interessato a quella sua intimità, l’avvocatessa rampante con il taglio moicano
rappresentava il prototipo di donna pronta all’uso di qualsiasi genere e per
ogni evenienza, la figlia d’un noto medico totalmente depilata era una che
credeva d’essere per quel fatto alla moda perché qualche fidanzatino con cui s’intratteneva
l’aveva così costretta ossessionato dalle migliaia di ore consumate con la
pornografia, la escort depilata completamente con piercing sul clitoride era
semplicemente una donna puramente dedicata al proprio lavoro capace di non far
interferire in quella soluzione di gestione vaginale i suoi gusti personali. La
sua era liscia e sgombra da qualsiasi peluria, come tutto il resto del corpo, perché
i motivi e le certezze erano ben chiari e assodate.
Non sopporto le altre donne perché noi
femmine, fondamentalmente, siamo stronze. Per questo odio mia madre ed in più
la odio perché è stupida –ma di lei non vorrei più parlare- detesto mia sorella
solo perché siamo gemelle, identiche, è come specchiarmi ogni volta che passa
mi davanti. Ma siamo così diverse pur essendo nate uguali. Come il prima e il
dopo la cura. Ma questa è la sorella che mi ritrovo. Io brutta e poco
interessante, lei bella e simpatica. Io che non riesco a combinare nulla
d’importante lei che riesce in tutto ciò che fa. Non sono invidiosa, non fa
parte della mia natura l’invidia, lei riesce però a farmi sentire distante con
ogni suo successo facendomi percepire in tutta la loro pochezza quelle che io
reputo soddisfazioni. Siamo semplicemente imparagonabili anche se tutti ci
paragonano. Passo oltre perché odio il confronto. Sinceramente non percepisco
le donne come rivali, semplicemente trovo il genere femminile stupido ed al
solo servizio del maschio che, inconsciamente, è reputato come depositario della
verità e del potere. Indistintamente. Ma i maschi non sono tutti uguali nel
senso che i veri maschi sono rari. Gli altri banali surrogati di un’idea che nemmeno
è ben troppo chiara alla maggior parte. Tu sei maschio, dominante, superiore
forse per la fisicità. Mi dovresti far sognare ed immaginare, il primo a farlo
dovrebbe essere il padre ma, il mio, non è riuscito a farmi sentire minimamente
così, nemmeno quando ero piccola ed ingenua. Anzi, se devo essere onesta, ho
avuto nei suoi confronti una sorta di repulsione sia fisica che mentale. L’ho
sempre trovato banale nel suo modo di porsi ed interagire, e nemmeno i suoi
rari abbracci o dimostrazioni d’affetto mi sono parsi veri ma posticci, sempre
percepiti come forzate dimostrazioni d’un sentimento che non andava veramente
oltre ad un ipocrita apparenza.
[…]
Come è finito tutto questo odio? Il
giorno in cui ho spaccato la faccia ad una stronza che mi aveva chiamata troia e solo perché, secondo lei, le
avevo tagliato la strada con l’auto. Dopo l’insulto è sgommata via, l’ho
inseguita nel traffico per quasi dieci minuti, poi l’ho raggiunta. Non so cosa
mi è preso, non è stata una reazione a caldo, era già ben raffreddata. Volevo
semplicemente massacrarla. E così ho fatto. Tutto sommato è stato abbastanza
semplice, le ho veramente tagliato la strada, sono scesa e ho aperto la sua
portiera prima che lei capisse cosa stava accadendo. Subito ha iniziato ad
urlarmi cose irripetibili, l’ho presa per il collo e l’ho tirata fuori, mi ha
dato una manata in viso che nemmeno ho sentito. L’ho scaraventata a terra e le
ho dato una serie di calci in pancia e così ha smesso di parlare. Le ho fatto
molto male perché indossavo i miei amati stivati texani…ma non mi sentivo
soddisfatta, l’ho presa così per i capelli e l’ho trascinata per un po’, lei ha
tentato da terra di colpirmi ed ha ripreso ad urlare. Le ho spaccato gli
incisivi con un colpo di tacco. Quando ho visto il sangue scorrere sull’asfalto
ho provato una sensazione di beatitudine e così l’odio s’è placato. Da quel
giorno quando sento di non poterne più cerco qualcuno da picchiare. Meglio se
trovo una donna. E questo funziona. Perché noi donne fondamentalmente siamo
delle stronze.